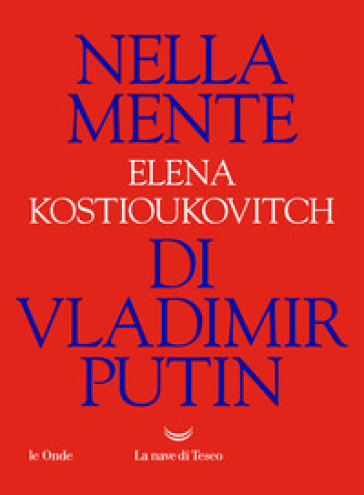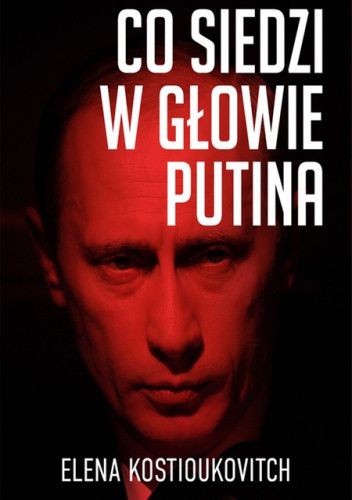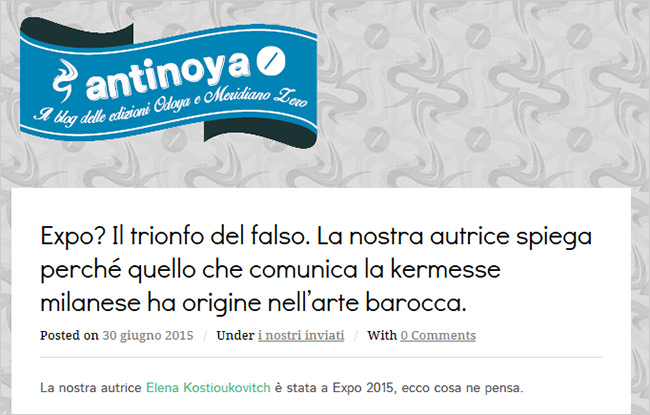
Expo? Il trionfo del falso. La nostra autrice spiega perché quello che comunica la kermesse milanese ha origine nell’arte barocca.
La nostra autrice Elena Kostioukovitch è stata a Expo 2015, ecco cosa ne pensa.
di Elena Kostioukovitch
“Il tema dell’EXPO 2015, il cibo, è in linea con il tema di una mia ricerca, frutto di dieci anni di lavoro e tradotta ormai in diciotto Paesi (Perché agli italiani piace parlare del cibo, III ed., Odoya 2015). Nel libro ci sono venti capitoli che parlano del cibo di varie regioni, con le loro implicite caratteristiche e altri venti dedicati a concetti diffusi nella società italiana, che hanno a che fare con la gastronomia e la nutrizione ( “Pasta”, “Pizza”, “Materie prime”, “I doni dell’America”, “Procedimenti”, “Totalitarismo”, “Eros” etc).
Una stessa struttura del materiale si intravede nell’impaginazione dell’enorme e festosa cartina dell’EXPO a Milano.
Ma, andando a esplorare la realizzazione “reale” di questa mappa mentale di contenuti, ho notato con quante difficoltà si sviluppi lì il processo comunicativo, materializzandosi nell’architettura e nel design di quel centinaio di padiglioni sparpagliati tra il carcere di Bollate e il cimitero di Verano, nello spazio triangolare vicino allo svincolo autostradale di Rho. Piuttosto di diventare sempre più chiaro, il messaggio intellettuale voluto dagli ideatori dell’EXPO viene oscurato dalle stesse tecnologie che avrebbero dovuto trasmetterlo. Si rafforza, invece, il lato emotivo di qualsiasi realtà ci capiti davanti agli occhi: si crea una dissonanza colossale tra ciò che il pubblico è invitato a pensare e ciò che lo stesso pubblico finisce per provare.
Se si voleva dire che il naturale è meglio dell’artificiale, il pubblico prova una sensazione radicalmente opposta, perché gli ideatori sono rimasti troppo affascinati proprio dall’artificiale, dalle tecnologie.
Soltanto nel Manierismo e nel Barocco, cioè nel Cinque- Seicento, gli uomini adoravano tanto la “meraviglia” voluta da Giovanbattista Marino: si cercava di ingannare i sensi del pubblico, presentando frutta e altri cibi in forma di oggetti minerali (non commestibili) e, al contrario, forgiando simulacri di cibo inverosimilmente naturali, tanto da volerli quasi azzannare.
Queste trasformazioni, noi le osserviamo in tutti i padiglioni dell’EXPO. Nel padiglione giapponese sushi virtuali sono serviti al pubblico nel ristorante elettronico, e devono essere presi con le bacchette, e una commessa spiega e controlla severamente se i visitatori sono capaci di tenere le bacchette correttamente. Il cibo però è immaginario, olografico. Nel padiglione kazako i visitatori credono di poter volare, grazie agli occhiali 3D, e poi tornano in una saletta piena di vasche dove tuonano avvisi del tipo: “Non dovete toccare con le mani i pesci!” Poi a sorpresa si scopre che la saletta è piena di storioni vivi.
Tutto questo altro non è che un tipico spettacolo barocco, di quelli descritti dai trattatisti del Seicento (Emanuele Tesauro), ma allestiti, ai giorni nostril, dallo scenografo Giancarlo Basili e dall’architetto Michele De Lucchi.
 Di quest’ultimo sappiamo per certo che il giorno dell’apertura dell’EXPO (Primo Maggio) ha urgentemente mandato la moglie a noleggiare buffetteria dallo storico fornitore del teatro alla Scala. Me l’ha raccontato la proprietaria della ditta E.Rancati di Cornaredo che gliel’ha noleggiato: dal deposito teatrale erano partiti per l’EXPO dieci metri di camion stipato di finte zucche, finti porcellini, finte bottiglie di vino di cartapesta. I creatori del grandioso evento hanno fatto ricorso ai precedenti barocchi o manieristici, cioè al periodo del trionfo del falso.
Di quest’ultimo sappiamo per certo che il giorno dell’apertura dell’EXPO (Primo Maggio) ha urgentemente mandato la moglie a noleggiare buffetteria dallo storico fornitore del teatro alla Scala. Me l’ha raccontato la proprietaria della ditta E.Rancati di Cornaredo che gliel’ha noleggiato: dal deposito teatrale erano partiti per l’EXPO dieci metri di camion stipato di finte zucche, finti porcellini, finte bottiglie di vino di cartapesta. I creatori del grandioso evento hanno fatto ricorso ai precedenti barocchi o manieristici, cioè al periodo del trionfo del falso.
E’ all’Arcimboldo che risalgono pure i giganteschi golem di Davide Rampello, che i milanesi da anni erano abituati a vedere all’entrata della Stazione Centrale e che ora marciano in colonna, minacciosamente, guardando il visitatore, subito all’entrata dell’EXPO, di fronte al Padiglione Zero. E’ il principio manierista quello di questo Padiglione Zero, dove gli animali in scala naturale, molto dettagliati, sono tutti trasformati in ectoplasmi di una nivea bianchezza.
 E’ al Manierismo che risalgono i panettoni ricamati con dei veri fili di lana, esposti accanto ai quadri cinquecenteschi nella mostra organizzata da Vittorio Sgarbi, che, bisogna dirlo, è peraltro il capitolo più valido, interessante e ricco di tutta la kermesse. Ma dai manuali di Storia dell’Arte si sa che queste nature morte, di cui fanno parte frutti (come la “Fiscella” di Caravaggio), trasmettevano l’idea di vanitas vanitatis, di tristezza, di morte. E infatti, in un modo subliminale, lo trasmettono pure gli allestimenti di questa EXPO. Credo che questo non sia proprio il risultato che era stato programmato! Peccato che avessero scelto come simbolo dell’EXPO 2015 quella cesta di frutta di caravaggesca memoria, con il rimando subconscio al memento mori, e pure di difficile lettura: ogni frutto antropomorfizzato funziona come il simbolo dell’EXPO, ma sono numerosi e ci si confonde. Vari Hello Kitty e coniglietti bianchi partecipano alle parate solenni come aventi diritto. E pensare che l’Italia disponeva di un intero catalogo di possibili mascotte!
E’ al Manierismo che risalgono i panettoni ricamati con dei veri fili di lana, esposti accanto ai quadri cinquecenteschi nella mostra organizzata da Vittorio Sgarbi, che, bisogna dirlo, è peraltro il capitolo più valido, interessante e ricco di tutta la kermesse. Ma dai manuali di Storia dell’Arte si sa che queste nature morte, di cui fanno parte frutti (come la “Fiscella” di Caravaggio), trasmettevano l’idea di vanitas vanitatis, di tristezza, di morte. E infatti, in un modo subliminale, lo trasmettono pure gli allestimenti di questa EXPO. Credo che questo non sia proprio il risultato che era stato programmato! Peccato che avessero scelto come simbolo dell’EXPO 2015 quella cesta di frutta di caravaggesca memoria, con il rimando subconscio al memento mori, e pure di difficile lettura: ogni frutto antropomorfizzato funziona come il simbolo dell’EXPO, ma sono numerosi e ci si confonde. Vari Hello Kitty e coniglietti bianchi partecipano alle parate solenni come aventi diritto. E pensare che l’Italia disponeva di un intero catalogo di possibili mascotte!
 Parlo di vari Porri seduti, Maghi melini, Foche melanzane e Ravanelli topolini delle campagne pubblicitarie dell’Esselunga anni Novanta. Bastava rispolverarne uno e si aveva una mascott efficace, carina, ricordabile e con un’italianissimo pedigree creativo. Peccato che a nessuno sia venuta in mente questa soluzione.
Parlo di vari Porri seduti, Maghi melini, Foche melanzane e Ravanelli topolini delle campagne pubblicitarie dell’Esselunga anni Novanta. Bastava rispolverarne uno e si aveva una mascott efficace, carina, ricordabile e con un’italianissimo pedigree creativo. Peccato che a nessuno sia venuta in mente questa soluzione.
E’ barocca (in senso metaforico) la quercia artificiale che ha richiesto 1400 ore di lavoro umano (assemblare minuscole scaglie di plastica…). E’ barocca (sul serio) la “Macchina di Santa Rosa”, trasportata all’EXPO da Viterbo, dove la portano ormai da cinque secoli per le vie della città ogni tre settembre. Guglie vere (!) tolte dal Duomo di Milano non hanno nessuna chance di rivelare la propria natura se disposte sul Decumano, accanto alla Madonnina, farlocca copia di quella situata in cima al Duomo, ma coperta, questa, di fogli d’oro zecchino (mentre quella vera e’ coperta soltanto di “povero” bronzo dorato). Rappresenta un originale storico, come lo rappresenta una ciotola egiziana che ha seimila anni, e i famosi grifoni “trapezoforos” (che risalgono al periodo della Magna Grecia e sono in assoluto uno dei primi esempi di marmi policromi conosciuti), portati qui dal lontano paesino di Ascoli Satriano in Puglia… per finire in un angolo non frequentato da nessuno dietro la reception del Padiglione Italia.
In questa generica atmosfera barocca, nessuno è capace di capire cosa è vero e cosa è falso. Il gioco barocco del Seicento era basato su una comunicazione giocosa, ma univoca, chi mangiava ostriche fatte di zucchero capiva cosa l’aspettava. Ma la maggior parte dei visitatori dell’EXPO, trovandosi davanti a un tavolo gigantesco fatto in legno Kauri pietrficato, che è preistorico e fossilizzato e rappresenta la Pangea (i continenti prima della deriva) con le gambe realizzate in briccola (di rovere, recuperate dalla laguna), non sa a cosa possa servire quell’enorme piattaforma circondata da panche disposte come in un anfiteatro. Un podio per ballare la macarena? Lo suggerisce la colonna sonora dal vicino altoparlante. Dopo mezza giornata all’EXPO, smettiamo di capire quale cosa di quelle che abbiamo visto sia vera, e quale sia finta, e sotto sotto ci convinciamo che la differenza tra il naturale e l’artificiale, tra il vero e il falso, in fondo non c’e. Possibile che sia stato questo lo scopo di una comunicazione nata per esprimere la priorità del naturale sull’artificiale?
Sicuramente questa comunicazione dovrebbe essere più precisa e più esplicativa. Invece in molti casi non si trovano neppure delle didascalie per le opere esposte. I quattro cavalli di Francesco Messina realizzati da lui per l’EXPO 1942 (quella di Roma, mai avvenuta) e provenienti da una collezione privata (collezione Leone), stanno all’incrocio tra il cardo Massimo, dedicato all’Italia, e il famoso decumano; il pubblico li tratta come se fossero dei cavallini di una giostra per bambini. Tolgo, sciogliendo un cordoncino annodato, un paio di palloncini colorati Mcdonald’s dall’orecchio di uno dei cavalli. “Sono quelli orignali di San Marco che prima stavano all’Ippodromo di Costantinopoli”, balbetta l’accompagnatore di uno dei gruppi turistici che si trascinano nelle vicinanze. La guida dice ovviamente un’illustre panzana, ma tutto e’ credibilie, tant’e’…
 Cosa vuole il robot coreano evaso dal padiglione, che mi corre dietro lungo la strada cercando di aggrapparsi a me con le sue chele? Mi fermo per parlare con lui, si allontana subito. E’ diverso il comportamento della polverosa aragosta in peluche: proferisce qualche battuta con un forte accento calabrese. Qui si delinea il problema della comunicazione incerta, smarrita, che non giunge all’utenza. Nel regno della comunicazione fine a se stessa, non solo si fraintende il segnale di partenza, ma è incerta proprio l’elaborazione dei segnali. I mezzi di cui le nostre civiltà dispongono nel mondo d’oggi sono troppo forti. La loro potenza supera la capacità di capire degli utenti. Ecco, l’EXPO rende visibile questo fatto. Potrebbe salvare la situazione il buon vecchio buon senso, ma questo, dolorosamente, manca.
Cosa vuole il robot coreano evaso dal padiglione, che mi corre dietro lungo la strada cercando di aggrapparsi a me con le sue chele? Mi fermo per parlare con lui, si allontana subito. E’ diverso il comportamento della polverosa aragosta in peluche: proferisce qualche battuta con un forte accento calabrese. Qui si delinea il problema della comunicazione incerta, smarrita, che non giunge all’utenza. Nel regno della comunicazione fine a se stessa, non solo si fraintende il segnale di partenza, ma è incerta proprio l’elaborazione dei segnali. I mezzi di cui le nostre civiltà dispongono nel mondo d’oggi sono troppo forti. La loro potenza supera la capacità di capire degli utenti. Ecco, l’EXPO rende visibile questo fatto. Potrebbe salvare la situazione il buon vecchio buon senso, ma questo, dolorosamente, manca.
Sara’ pure di chiara lettura la pianta del complesso espositivo (anche se i nomi di “decumano” e “cardo” potrebbero essere sostituiti con “avenues” e “streets” perché l’insieme assomiglia più a Manhattan che agli accampamenti romani, i quali non erano cosi’ allungati ma piuttosto rotondi).
 Comunque è un piano valido: ma dove sta il senso pratico se la direzione dà il permesso di dividere questa cittadina per una giornata intera con un invalicabile “muro di Berlino”, visto che il decumano era bloccato, in un modo scandaloso, da una pizzaex surgelata record Guinness lunga 1600 m?
Comunque è un piano valido: ma dove sta il senso pratico se la direzione dà il permesso di dividere questa cittadina per una giornata intera con un invalicabile “muro di Berlino”, visto che il decumano era bloccato, in un modo scandaloso, da una pizzaex surgelata record Guinness lunga 1600 m?
Si sarebbe dovuto ricorrere di più al buon senso nella sfera organizzativa, ma ancora di più in tutte le decisioni nel campo della comunicazione, che è la linfa vitale di un evento come questo. Quale linguaggio verbale bisognava adottare? Sembra di tornare nel periodo barocco, alle “discussioni sulla lingua ideale”. In ogni padiglione regna la propria lingua, con una sbrigativa traduzione eseguita da stanchi addetti che ci lavorano, traduzione sempre in lingua italiana! In inglese trovi poco, pochissmo. Come si fa a chiamare questa esposizione “universale”?
Ma anche se fosse tutto a posto con l’inglese, rimarrebbe, temo, irrisolto il problema più difficile in assoluto: trovare la giusta proporzione tra i linguaggi verbali e quelli non verbali, per rendere percepibile il gigantesco flusso di informazioni. Didascalie? Non basterebbe occupare lo spazio di tutti i muri…
Cercano disperatamente dei modo di farlo i tedeschi, con la loro proverbiale pedanteria. Danno a tutti in mano un cartoncino (lo chiamano Seedboard), su cui vengono proiettati, come per magia, fiumi di parole, tutte olografiche. I visitatori si stufano di leggere, piegano il cartoncino, si difendono dall’overdose di parole.
La maggioranza di quelli che hanno visitato il padiglione inglese non ha capito, in fondo, che il vistoso alveare in acciaio, orgoglio principale dell’allestimento della Gran Bretagna, è connesso con un vero alveare del laboratorio scientifico alla Nottigham University e ogni ape che si sposta lì agisce sulle lampadine montate all’interno della cupola metallica del padiglione qui in Italia. Per spiegarlo ci vorrebbero tante parole! Per giunta in inglese.
“Parole, parole, parole…”. Forse, qui ci vorrebbe qualche altro mezzo d’espressione. La scienza di schemi e schede, disegni e simboli, che si chiama “infografica”, avrebbe potuto raggiungere proprio qui, nelle sale dell’EXPO, l’apice del suo massimo sviluppo.Ma qualcosa l’ha impedito. E’ mancato il tempo? Gli stimoli? La fantasia? La voglia?
Comunque, il fatto è che non si è puntato sulla cognizione, ma sull’emozione.
L’espressività emotiva si materializza nella forma di una vera abbuffata di luci. Se non è luce, è buio. Un buio trafitto da aspri raggi dinamici (come nel padiglione giapponese), oppure il buio totale (in una sala del Padiglione Italiano).
 Dominano su tutto luci accecanti, che culminano nello stesso Padiglione Italia, dove i più incantevoli paesaggi e architetture italiane appaiono su uno schermo al plasma di potenza spaventosa, e sono pure quintuplicati da pareti, soffitto e pavimento interamente fatti di specchi luminosi. Tutto è bellissimo e aggressivo. Questa elaborazione li rende (di nuovo) artificiosi, diversi dai soliti paesaggi da cartolina che fosse Petrella Tiferina di Campobasso, o il Duomo di Monreale, o il Castello Ducale di Corigliano Calabro, o la pavimentazione della Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno… Tanto le didascalie comunque sono assenti.
Dominano su tutto luci accecanti, che culminano nello stesso Padiglione Italia, dove i più incantevoli paesaggi e architetture italiane appaiono su uno schermo al plasma di potenza spaventosa, e sono pure quintuplicati da pareti, soffitto e pavimento interamente fatti di specchi luminosi. Tutto è bellissimo e aggressivo. Questa elaborazione li rende (di nuovo) artificiosi, diversi dai soliti paesaggi da cartolina che fosse Petrella Tiferina di Campobasso, o il Duomo di Monreale, o il Castello Ducale di Corigliano Calabro, o la pavimentazione della Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno… Tanto le didascalie comunque sono assenti.
Allora, poco male che questi luoghi diventino parti anonime di una complessa macchina barocca teatralizzata, potenziata con la luce fino all’irriconoscibilità. Luci abbaglianti, suoni assordanti: insomma, una vera discoteca.
Si esce dopo aver visto migliaia di interessanti cose vere senza aver potuto distinguerle da quelle false. Si esce con una forte carica emotiva dovuta all’eccitazione dei ricettori visivi, uditivi e naturalmente gustativi e olfattivi (cibo dappertutto, a volte irrangiungibile per colpa di file interminabili o di prezzi proibitivi). Tutto ciò fa nascere nel visitatore una certa sensazione di falsità, lui sospetta di avere contribuito a confondere lo spreco con il risparmio, la vanita’ con la dedizione. Il contrario del previsto: a maggior ragione che, tanto per dire, il padiglione Vaticano è costato il triplo della cifra che basterebbe per sfamare per un anno i senzatetto di Roma, il che giustamente ha suscitato l’ira del pontefice Francesco I, sensibile, come sappiamo, a queste problematiche.
Ecco, lui sì che nel campo della comunicazione assertiva non ha mai fatto cilecca. Per orientarsi in questa sfera futuristica bisogna per caso essere gesuiti?”