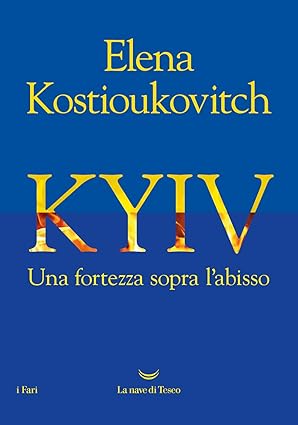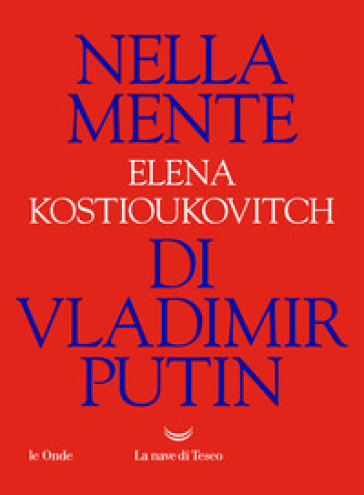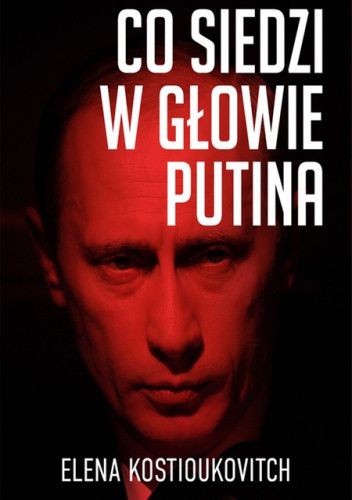Huffington Post Italy, 30 August 2025 - Elena Kostioukovitch's article on Huffington Post Italy: "Words as weapons, and conflicts born from ideas"
Le parole come armi e i conflitti intorno alle idee
di Elena Kostioukovitch

“Le parole sono importanti”: la frase di Nanni Moretti in Palombella rossa è diventata proverbiale. Sotto il regime sovietico, le parole erano il principale pericolo per lo Stato; oggi, in Russia, il loro peso si misura in anni di carcere.
Il titolo del libro di Marcello Flores - "Le parole hanno una storia" (Donzelli, 2025, 154 p.) - richiama anche una poesia di Vladimir Majakovskij, scritta poco prima del suicidio e pubblicata postuma:
Le parole: campane d’allarme.
Non applausi. Non salotti.
Smuovono le bare dei morti – e le bare
si mettono in cammino a quattro zampe...
Flores mostra come le parole possano scuotere popoli e governi, ma anche paralizzarli, deformarli, imprigionarli. Alcuni leader contemporanei ne fanno un’arma: molte dichiarazioni di Trump, anche le più gravi, non sono linee politiche ma parte di una strategia comunicativa. Servono a confondere, a “inondare” l’avversario, che si tratti dei democratici o dei media.
Il presupposto di Flores è netto: Orwell ha dimostrato che con le parole, manipolate, “qualcuno di molto pericoloso” può spingere masse inizialmente ingenue o distratte in una trappola sociale senza via d’uscita. Una volta caduti, anche quando la falsità è smascherata, non ci si libera più.
È ciò che è accaduto all’élite intellettuale russa. Sconsiderata, distratta, oggi si interroga con rimorso: “Dove eravamo, eredi di Tolstoj e Dostoevskij, in quei venticinque anni in cui il KGB si riprendeva il potere? Non ci accorgevamo che la pelle di zigrino della libertà si restringeva di giorno in giorno?” Quell’élite, cane da guardia della morale, non ha percepito il mutamento radicale del clima politico. Un cambiamento che iniziava — significativamente — dal linguaggio, dalla retorica, dal lessico.
Qualcosa di simile accade anche nelle società più libere. Il XXI secolo era cominciato con un’illusione di solidarietà globale, con discussioni su come riformare le Nazioni Unite. Ma dopo il suo primo quarto, ci troviamo davanti a sfide pazzesche — nel senso letterale: capaci di far impazzire.
Flores lo vede e lo analizza con lucidità. La sua è un’analisi storica che lascia risuonare le campane d’allarme di Majakovskij. È ricerca accademica, fondata su decenni di studio, ma anche infinitamente attuale. Storico di rilievo internazionale, fondatore di Memorial Italia (la “casa madre” russa dell’ONG è stata premiata nel 2022 con il Nobel per la Pace), autore di oltre venti libri fondamentali sul Novecento globale — tra cui Storia dei diritti umani (2008) e Verità e menzogna nella storia (2009) — Flores scrive con la precisione del ricercatore e l’urgenza del testimone.
La prima parte del volume è dedicata al XIX secolo e alle radici storiche, politiche e concettuali di parole-chiave come diritti umani, colonialismo, razzismo, genocidio. Flores analizza la diffusione del razzismo pseudoscientifico, con attenzione ai primi campi di concentramento — da quelli britannici in Sudafrica durante la guerra anglo-boera al Congo di Leopoldo II — e mostra come la scienza (o meglio, il suo abuso) “naturalizzi” il razzismo. Poi racconta come la Prima guerra mondiale introduca il concetto di “crimini contro l’umanità” a partire dal genocidio armeno del 1915. Nel 1941 Roosevelt, nel suo famoso discorso, allarga l’orizzonte etico: libertà di parola, di religione, libertà dal bisogno e dalla paura.
La seconda parte affronta il secondo dopoguerra. Dopo la Dichiarazione universale del 1948, il progetto dei diritti umani è ostacolato, respinto o reinterpretato. I Paesi del Sud globale vedono nell’universalismo un nuovo colonialismo morale. Tre ostacoli principali frenano la piena affermazione dei diritti: relativismo culturale, sovranità statale, resistenze ideologiche. Si consolida così la frattura tra diritti civili e politici (modello occidentale) e diritti economici e sociali (rivendicati soprattutto da Est e Sud del mondo).
La terza parte è organizzata in capitoli brevi e incisivi. Flores analizza parole come Apartheid, Colonialismo, Crimini di guerra, Genocidio, Pogrom, Sionismo. Mostra come termini nati con un significato giuridico o storico preciso vengano oggi logorati dall’uso improprio o dalla strumentalizzazione politica. “Genocidio” diventa un’arma retorica; “pogrom” e “sionismo” vengono deformati fino a perdere il loro senso originario. L’inflazione linguistica, ammonisce Flores, può portare alla relativizzazione del crimine.
Qui sta il cuore del libro: non è solo storia delle idee, ma storia dei conflitti intorno alle idee. E conflitti che passano per le parole hanno conseguenze reali. “La corretta definizione delle parole è uno degli strumenti fondamentali di analisi e confronto, di formazione e acquisizione del sapere e, in ultima istanza, di tutela della democrazia e della convivenza civile”, - conclude l’autore.
Ed è anche la via indicata a chi non vuole arrendersi: lavorare, resistere, smontare le parole tossiche prima che colonizzino il pensiero. Perché oggi il lessico della politica e della guerra ci aggredisce ogni giorno. “Conflitto” sostituisce “Aggressione”; “Incursione” rimpiazza “Attacco criminale”; “Danni collaterali” nasconde “civili uccisi”. Parole eleganti e apparentemente neutre — “Echo chamber”, “Infodemia” — coprono operazioni di controllo e manipolazione.
In Russia, l’acronimo SVO (iniziali delle parole russe che vogliono dire “Operazione militare speciale”) sostituisce “guerra”; la parola “pace” può costare il carcere. E chissà cosa accadrebbe a chi, in una piazza russa, osasse esibire Guerra e pace di Tolstoj.
Anche l’Ucraina combatte la sua guerra linguistica. La lingua è colla nazionale. Come disse Edward R. Murrow di Churchill — frase poi ripresa da Kennedy — “ha mobilitato la lingua inglese e l’ha mandata in prima linea”, così Zelensky ha mobilitato l’ucraino.
Nelle trincee, canzoni e parole salvano vite. Lo shibboleth “palyanytsya” (“pagnotta”) serve a riconoscere chi è amico. Pronuncialo bene, e sarai accolto come un fratello. “Slava Ukraini” è diventata un Gradale: un’invocazione che dà forza a chi la grida.
E, addirittura, anche una singola preposizione è questione di vita o di morte. In Ucraina è malvisto chi dice Na Ukraine (“nell’Ucraina”), approvato chi dice V Ukraine (“in Ucraina”); in Russia è l’opposto. Tra l’una e l’altra, come sanno i lessicografi e, tragicamente, gli anatomopatologi, si aprono abissi di sangue.
---------------------------------------------------------------------------
Full article here: